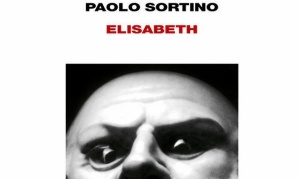Ha sentito il tocco … Poi ne ha dipinto la leggerezza.
Il segreto di Elisabeth
L’incipit di Elisabeth, il romanzo di Paolo Sortino pubblicato da Einaudi, è un’iscrizione nel vento; un presagio indefinito nella sua terribile delicatezza; echeggia in esso, come il rumore del mare in una conchiglia, la deflagrazione dell’ordinario: « Erano gli ultimi giorni e non lo sapeva». La storia vera di Elisabeth Fritzl rinchiusa per quasi ventiquattro anni nel bunker antiatomico progettato dal padre diventa letteratura; per l’autore la forma entro cui far colare un significato, la propria idea di felicità.
Le prime pagine così leggiadre, sono il riflesso di una spensierata illusione; raccontano nello spazio che sfugge la sorveglianza dei genitori gli slanci di una giovinezza. Elisabeth sta preparando il suo viaggio insieme alla sua più cara amica mentre il padre sta scontando i suoi giorni in prigione dopo essere stato accusato di alcuni stupri; un’assenza questa che le fa assaporare il gusto di una libertà mai conosciuta. Durerà ancora per poco questo tempo idilliaco; nessun presentimento l’avvolge e questo la rende ancora più commovente. Ottenuta la scarcerazione Josef farà ritorno nella sua casa; il terrore di ripiombare nell’angustia fatta di «orari proibiti, disapprovazione per i suoi vestiti, gelosia» scatena in lei il bisogno di una fuga: lontano dal quel muro di carne che avrebbe frustrato di nuovo i suoi desideri di ragazza. Sotto un cielo di una «serenità patetica» si compie il suo mal riuscito tentativo di evasione; la sua ricerca di quel punto che avrebbe ripristinato i suoi rapporti col mondo viene interrotta dalla solerzia della polizia che, ignara della propria azione, riconsegna Elisabeth nelle mani del suo futuro aguzzino.
Mentre la routine domestica riempie l’appartamento dei Fritzl, Joseph all’oscuro delle sue donne si prodiga nel realizzare l’inimmaginabile; ordina una quantità enorme di materiale edile che invade lo scantinato. Nell’apparenza di un normale cittadino, discreto ed educato si annida la volontà di costruire un nuovo piano di realtà sottostante a quella che ormai pareva averlo stancato del tutto. Nell’arco di qualche settimana Joseph, dopo aver assoldato i muratori più prestanti, completa la sua architettura sotterranea; come «un demone uscito dalla terra» disegna il suo labirinto entro cui ripercorrere «tutte le età dell’uomo fino al luogo in cui lo scorrere del tempo rallenta e da dove, ammesso che si sopravviva, si assiste alla nascita di ogni cosa». Il bunker, quindi, come spazio ideale per contemplare insieme alla sua vittima l’origine del cosmo.
La chiusura dei lavori coincide con il diciottesimo compleanno di Elisabeth, la quale, dopo aver trascorso i suoi ultimi istanti di serenità con la sua amica Rosvita, inizierà la sua discesa agli inferi. Ventiquattro anni imprigionata nel sogno mostruoso di suo padre che, dopo averla messa al mondo, adesso vuole assimilarla nel suo di mondo. Precipitata in questo buco al di sotto dell’umanità, Elisabeth è l’ultimo suddito di un regno che si fonda sulla violenza più selvaggia; adesso la sua vita appartiene al padre che ne può disporre liberamente. Joseph entra ed esce dal suo corpo ogniqualvolta è dominato dalla voglia; va incontro alla sua tenera carne «come un’onda enorme che uscendo dal mare investe in pieno una bambina che si stava voltando». Infine per assicurarsi che la polizia non arrivi un giorno a disfare le sue trame costringe Elisabeth a scrivere una lettera; in questa ennesima menzogna nella quale la ragazza parla di una fuga con delle persone sconosciute con cui si trova bene, brilla però un granello di verità: «è gente che adora Satana – si legge sul foglio – che è pur sempre un angelo rispetto a papà».
Nel momento stesso in cui Elisabeth asseconda la vita, scegliendo di non uccidersi, si accende in lei «un lavoro senza pari per la sopravvivenza». Comprende nella cattività che il vero nemico contro cui lottare non è più il padre, di cui ormai ha imparato il linguaggio, ma se stessa. Ridotta ai minimi termini acquisisce la necessaria consapevolezza che ribellarsi a quello stato di cose è uno di quei gesti che porterebbe ad uno sterile sfinimento. Elisabeth dopo aver toccato il punto più basso della sua esistenza opera una mimesi con il contesto che fino a quel momento l’aveva oppressa: « il bunker ora le apparteneva come un’indole». Joseph vede la propria creazione trasformarsi in uno specchio in cui si riflette accecante la sua paura. La vigorosa capacità di iniziativa finora posseduta comincia ad indebolirsi e lo porterà con quel suo «modo stanco di pensare» ad essere totalmente inoffensivo. Perché si sa il male quando è messo di fronte a sé stesso scopre la radice della propria monotonia.
Al contempo però se l’impotenza di fronte alla orgogliosa virilità del genitore inizialmente atterriva e paralizza la ragazza improvvisamente la mette in contatto con una zona invisibile del suo essere a cui al padre non è dato di accedere. Proprio qui germina il segreto di Elisabeth che in quel mondo segreto in cui è stata rinchiusa accresce ogni giorno la sua forza; nell’animo del lettore rimane impresso una sorta di negativo, un’ecografia che reca sul suo piano l’informità di un desiderio.
Nel corso di questi lunghissimi anni nella fissità di una vita che acuisce i suoi sensi questa giovane donna attraverserà per sei volte il tempo della gestazione generato dai rapporti incestuosi con il padre. Nella solitudine agghiacciante in cui ha vissuto, i suoi sette figli sono stati una drammatica compensazione; avere qualcuno di cui prendersi cura l’ha aiutata a colmare i vuoti della sua triste esistenza; alcuni di loro sono stati portati da Joseph sull’uscio di casa simulando l’abbandono della madre.
Il più sfortunato invece nato da un parto gemellare avrà perso la vita a causa degli indugi del padre che non assumendosi il rischio di portarlo in ospedale – dove sarebbero potuti sorgere indizi tali da insospettire le autorità – lasciandolo morire nell’incuria. Il capitolo sulla morte del piccolo Michael intitolato l’inverno più caldo è tra i più belli ed avvolgenti; la prosa si fonde con le atmosfere descritte sopra e sotto il bunker. Nonostante venga compiuto uno degli atti più disumani del testo il lettore sprofonda nella lenta spirale di un incendio incapace di estinguere definitivamente le tracce del piccolo cadavere.Ed è nel vuoto ineffabile lasciato dalla morte del suo bambino che Elisabeth libera, come una corda nell’infinito, il suo anelito di salvezza rimasto per tutti quegli anni nella bolla della sua inviolabile intimità.
Filippo Deodato
L’uomo che cammina
L’Azenda perpetua e l’arte di sorridere

Conosciamo quasi tutti quella bellissima frase di Charlie Chaplin: «Un giorno senza un sorriso è un giorno perso». Non ci accorgiamo però, che molto spesso, afferriamo solo con la mente ciò che invece dovremmo abbracciare con tutta la generosità del nostro spirito. Ci siamo mai chiesti quale sarebbe quell’irreversibile ed irreparabile spreco che nasce ogniqualvolta lasciamo passare un giorno senza aver elargito neppure un sorriso? Sfogliare le pagine dell’Azenda perpetua, opera del suo misterioso autore Beppebeppetti e in libreria per Add editore dal mese di ottobre, può aiutarci a rispondere. Il sorriso è la finestra dell’anima più grande, quella che consente non solo un transito maggiore di onde luminose, ma di scorgere più cose. Erroneamente lo si circoscrive alla sola bocca, quando in realtà, oltre a muovere tutti i nostri muscoli con la sua forza prorompente, investe l’espressione dei nostri occhi e, dopo averne dilatato le pupille, ne accresce la loro profondità e la loro bellezza.
Dentro le pagine gioiose di questa singolare agenda, ‘perpetua’ per l’assenza dell’anno che ne possa delimitare la sua validità, vive il protagonista, Dadgad, così carico di umanità; saltellante e allegro, con quel suo corpicino minuto che pare una timida ombra al cospetto di quel suo capo straordinariamente gigante e volutamente spazioso, su cui domina l’immancabile semicerchio del suo sorriso.
Questo buffo e divertente omino dalle braccia elastiche e dalla duplice triade di capelli che germoglia dalla sua rotondità, è attraversato dalla mutevole e umana gamma degli umori; non è ignaro delle spiacevoli vicende che puntellano la nostra esistenza e che spesso gli provocano amare riflessioni come questa: «alcuni uomini sono passati tristemente alla storia ma meritavano di passare alla geografia mandati a quel paese da molti popoli». Certo rimane invidiabile la sua leggerezza che lo pone eternamente in fuga dai pesi quotidiani che un mondo dispettoso tenta di propinargli. La capacità di Dadgad di ironizzare sui contrattempi, sulla nostra malcelata pigrizia e sulle nostre presunte certezze alimenta il nostro brio e la sua simpatica saggezza è un antidoto contro le nostre disillusioni. La sua delicata ironia è un invito elegante a prenderci meno sul serio e ad accettarci con tutti i nostri inestinguibili difetti; perché riderci sopra, sembra ricordarci Beppebeppetti, non rappresenta solo un gesto di riconciliazione con il mondo e con noi stessi ma un modo giocoso per allontanare e arginare quell’aggressività, pronta a offendere, e che giace latente nel nostro lato più oscuro.
Si, sorridere è un arte. Questo insegna con la sua magica matita il creatore di Dadgad. Un arte che richiede un costante e faticoso esercizio perché Il sorriso non è un’attitudine naturale e una risposta superficiale ai problemi della vita; «per sorridere» – dice Enzo Bianchi – «occorre padronanza di cuore […] il vero sorriso è accoglienza, è apertura del volto all’altro».
In una delle pagine di questo testo che potremmo definire un’ode figurativa al buonumore, c’è un piccolo disegno che se riusciamo a far nostro, potrà esserci utile a mutare il nostro modo di vedere ciò che ci circonda: Dadgad con un viso rilassato e compiaciuto è alla finestra e mentre alle sue spalle, dal di dentro della sua casa fuoriesce un bellissimo arcobaleno, sussurra tra sé e sé:« Non è importante sapere dove finisce l’arcobaleno … Ma da dove inizia». Come a dire che la sorgente da cui sgorgano tutti i colori è riposta nel fondo di ognuno di noi. E sorridere può aiutare a ritrovarla evitando ulteriori sprechi: anche questo sembra suggerire il nostro amabile Dadgad.
Una passeggiata sopra i tetti di Gerusalemme
 È un luogo che sembra nascondersi, eppure, una volta raggiunto, ci si sente come incoronati dall’immensa volta del cielo. Si accede all’angolo di St Mark’s Road e Khabad Street laddove i quartieri ebraico, cristiano e mussulmano si compenetrano, tramite una piccola scalinata in ferro che s’inerpica sicura verso un mondo altro, sospeso ma accogliente. Ad ogni scalino percorso si sente diminuire lentamente l’intenso rumore del tumulto di voci che gremisce gli affollati mercati. È un luogo di quiete, elevato sopra gli umori aspri di uomini in perenne conflitto, mistica terrazza distesa sopra l’intricato e affascinante labirinto, disegnato all’interno delle mura, di una delle più belle città del mondo: Gerusalemme.
È un luogo che sembra nascondersi, eppure, una volta raggiunto, ci si sente come incoronati dall’immensa volta del cielo. Si accede all’angolo di St Mark’s Road e Khabad Street laddove i quartieri ebraico, cristiano e mussulmano si compenetrano, tramite una piccola scalinata in ferro che s’inerpica sicura verso un mondo altro, sospeso ma accogliente. Ad ogni scalino percorso si sente diminuire lentamente l’intenso rumore del tumulto di voci che gremisce gli affollati mercati. È un luogo di quiete, elevato sopra gli umori aspri di uomini in perenne conflitto, mistica terrazza distesa sopra l’intricato e affascinante labirinto, disegnato all’interno delle mura, di una delle più belle città del mondo: Gerusalemme.
L’ora migliore per visitare questo meraviglioso spettacolo all’aperto è il crepuscolo, quando il sole si ritira lentamente e fa rosa il cielo e la luce indora ogni superficie. Sopra un gruppo disordinato di parabole satellitari, muri divisori, balconi con ringhiere corrose dal tempo e ogni sorta di ferraglia ci è possibile mirare l’oro luccicante della cupola della Roccia, che si erge ieratica, vertice maestoso e simbolo indiscusso della città vecchia. Trova posto anche un accenno di degrado abitato dagli echi delle risa dei bambini che un tempo riempivano un campo giochi ormai fatiscente e abbandonato. E poi, quell’insolita veduta della chiesa del Santo Sepolcro, protesa in alto come in fuga dai copiosi cordoni di vocianti turisti che popolano il suo interno così complesso. Tra sporadiche boccate di fumo svetta imponente la torre della chiesa luterana del Redentore parte integrante della chiesa neoromanica costruita dal Kaiser tedesco Guglielmo II nel 1898, la quale attesta un redivivo interesse da parte dell’Europa alla fine del XIX secolo per la Terra Santa.
Ma quello che più di ogni altra cosa incanta e rende questo posto unico al mondo è la sequenza di pochi densissimi istanti; quelli riempiti dal suono vibrante e lamentevole del canto del Muezzin, dal rintocco cadenzato e umile delle campane e dalla vista improvvisa degli ebrei ortodossi che passeggiano meditabondi. Fa esultare l’anima questa pacifica e contemporanea epifania delle tre grandi fedi monoteiste. Sazi e con il cuore disteso non rimane che rispondere al sollecito naturale dell’imbrunire che ci avverte che è tempo di andare.
Testo e foto: Filippo Deodato